 |
 |
|||

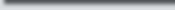
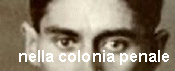
Ricordando la ferrovia di Kalda
[Diari, quaderno 7, fine agosto 1914:]
Per un certo tempo nella mia vita - sono ormai passati molti anni - ho lavorato in una piccola stazione nell’interno della Russia. Non sono mai stato così abbandonato come laggiù. Per diverse ragioni che ora non vale la pena ricordare, in quel tempo ero alla ricerca proprio di un posto del genere, e quanto più ero assediato dalla solitudine tanto più ero contento, e dunque non voglio neppure ora lamentarmene. Nei primi tempi, l’unica cosa che mi mancava era il da fare. Originariamente, la piccola ferrovia era stata costruita per qualche ragione commerciale, il capitale però non era bastato, la costruzione si era interrotta e invece di portare a Kalda, il centro più grande, distante da noi cinque giorni di viaggio in carrozza, la ferrovia si fermava in un piccolo insediamento nel mezzo di un deserto, dal quale, per arrivare fino a Kalda, ci voleva ancora un intero giorno di viaggio. Ora, anche se fosse arrivata fino a Kalda, la linea sarebbe stata non redditizia per un tempo imprevedibile, perché tutto il suo progetto era sbagliato, il paese aveva bisogno di strade e non di ferrovie; ma nello stato in cui la linea si trovava attualmente non poteva in generale neppure esistere, i due treni che passavano ogni giorno portavano un carico che avrebbe potuto viaggiare su una carrozza leggera, e i passeggeri erano soltanto, d’estate, un paio di contadini. Tuttavia non si voleva abbandonare del tutto la linea perché si sperava, mantenendola in attività, di attirare capitali per finire la costruzione. Anche questa speranza, a mio parere, non era una vera speranza, ma piuttosto disperazione e pigrizia. Si faceva viaggiare il treno finché fossero durati materiale e carbone, si pagava a un paio di operai uno stipendio irregolare e decurtato, come se si trattasse di una gratificazione, e per il resto si aspettava che il tutto cadesse in rovina.
In questa ferrovia dunque ero impiegato, e abitavo in una catapecchia di legno che era rimasta là dai tempi della messa in opera della linea, e che contemporaneamente serviva da costruzione di servizio. Aveva un’unica stanza, nella quale si trovava una panca per me e un leggio per il caso che dovessi scrivere qualcosa, e su di esso era collocato l’apparecchio del telegrafo. Quando arrivai, in primavera, l’unico treno passava nella stazione molto presto la mattina - più tardi questo fu modificato - e a volte succedeva che qualche passeggero scendesse mentre ancora dormivo. Naturalmente non rimaneva allora all’aperto - le notti erano laggiù molto fredde fino a metà dell’estate - ma bussava, io aprivo, e passavamo spesso ore intere a chiacchierare. Io me ne stavo sulla mia panca, il mio ospite si accoccolava sul pavimento o su mia indicazione bolliva il tè, che poi si beveva insieme d’amore e d’accordo. Tutta questa gente di campagna è tipicamente molto socievole. Io d’altra parte mi ero accorto di non essere tagliato per una completa solitudine, anche se dovevo confessare a me stesso che questa solitudine che mi ero scelto cominciava, già dopo poco tempo, a disperdere le mie preoccupazioni di un tempo. In linea generale ho accertato che una infelicità dimostra grande forza, se riesce a mantenere il suo potere su un uomo in solitudine. La solitudine è più potente di ogni altra cosa, e spinge di nuovo verso gli uomini. Naturalmente allora si tenta di trovare nuove strade, in apparenza meno dolorose, in realtà solo sconosciute.
Laggiù mi unii alla gente più di quel che avevo pensato. Naturalmente non si trattava di un rapporto regolare. Dei cinque villaggi che potevo considerare, ciascuno era lontano diverse ore sia dalla mia stazione, sia dagli altri villaggi. Io non potevo allontanarmi troppo dalla stazione, se non volevo perdere il posto; e questo, almeno nei primi tempi, non lo volevo affatto. Dunque non potevo andare io stesso nei villaggi e dovevo fare affidamento sui passeggeri in transito o su persone che non esitavano ad affrontare la lunga strada per farmi una visita. Già nel primo mese avevo trovato persone del genere, ma per quanto fossero amichevoli era facile capire che venivano solo per fare affari con me; e d’altronde non nascondevano neppure questa intenzione. Portavano diverse merci, e nei primi tempi, quando avevo denaro, compravo di solito tutto quasi alla cieca, tanto mi erano gradite le persone, specialmente alcune. Più tardi però limitai gli acquisti, fra l’altro anche perché credetti di notare che il mio modo di comprare risvegliava il loro disprezzo. Oltre a ciò, attraverso la ferrovia mi arrivavano mezzi di sostentamento, che però erano di scarsa qualità e persino molto più cari di quelli che mi portavano i contadini. All’inizio avevo anche pensato di allestire un piccolo orto per la verdura, di comprare una mucca e rendermi così, per quanto possibile, indipendente da tutti. Avevo anche portato con me attrezzi da giardino e sementi, terreno ce n’era a volontà e si estendeva intorno alla mia capanna, privo di qualsiasi costruzione, in singole superfici senza la minima rilevatezza fin dove l’occhio poteva arrivare. Ma io ero troppo debole per vincere questo terreno, un terreno riluttante duro e ghiacciato in primavera e che si opponeva anche alla mia zappa nuova e tagliente. La semente che vi spargevo andava perduta. In questo lavoro ebbi degli attacchi di disperazione. Allora me ne stavo giorni interi sulla mia panca, e non uscivo neppure all’arrivo dei treni. Mi sporgevo con la testa dall’oblò che era proprio sopra la panca, e annunciavo di essere malato. Il personale del treno allora, che consisteva di tre persone, entrava da me per riscaldarsi, ma non trovava molto calore, perché per quanto possibile evitavo di usare la vecchia stufa di ferro, che avrebbe potuto esplodere facilmente. Piuttosto rimanevo avvolto in un vecchio mantello caldo, coperto da diverse pelli che avevo via via acquistato dai contadini. "Ti ammali spesso" mi dicevano "sei un uomo malaticcio. Non te ne andrai mai più da qui." Non lo dicevano per rattristarmi, ma perché si sforzavano per quanto possibile di dire la verità nuda e cruda. Per lo più dicevano questo spalancando gli occhi in un modo del tutto particolare.
Una volta al mese, ma sempre in momenti diversi, veniva un ispettore per controllare il mio registro, ritirare i soldi incassati e - questo però non sempre - pagarmi lo stipendio. Il suo arrivo mi era sempre annunciato il giorno prima dalle persone che lo avevano fatto scendere alla stazione precedente. Ritenevano che questo annuncio fosse il più grande beneficio che mi potessero fare, anche se naturalmente avevo tutto in ordine ogni giorno. Inoltre, non c’era
[Diari, Convoluti:]
bisogno, per questo, del minimo sforzo. Ma anche l’ispettore ogni volta entrava in stazione con l’aria di dover scoprire, stavolta, tutte le mie manchevolezze. Spalancava sempre la porta con un colpo del ginocchio e mi guardava. Non faceva in tempo ad aprire il mio registro che vi trovava un errore. Ci voleva molto tempo perché, ripetendo il calcolo diverse volte davanti ai suoi occhi, lo convincessi che non io, ma lui aveva sbagliato. Era sempre insoddisfatto delle mie entrate, infine chiudeva il registro con un colpo e mi guardava di nuovo con severità. "Dovremo chiudere la ferrovia" diceva ogni volta. "Andrà a finire così" rispondevo io di solito.
Finito il controllo, il nostro rapporto cambiava. Io preparavo sempre qualcosa da bere, e se possibile qualche dolciume. Si beveva insieme, lui cantava con voce discreta, sempre però le stesse due canzoni, una era triste e cominciava: Dove vai fanciul nella foresta?, l’altra era allegra e iniziava così: "Lieta compagnia, sono uno di voi!" A seconda dell’umore in cui mi riusciva di metterlo, ricevevo in parte il mio stipendio. Ma solo all’inizio di questi rapporti lo consideravo con un certo rispetto, più tardi diventammo del tutto solidali, insultavamo senza ritegno l’amministrazione, mi sussurrava all’orecchio segrete promesse circa la carriera che voleva farmi ottenere, e alla fine ci gettavamo insieme sulla panca in un abbraccio che spesso non scioglievamo per dieci ore. Il mattino dopo se ne andava, ed era di nuovo il mio superiore. Io stavo davanti al treno e lo salutavo, lui salendo si voltava di solito ancora una volta verso di me e diceva: "Allora amico mio, ci rivediamo fra un mese. Tu sai cosa è in gioco per te." Vedo ancora adesso il suo volto gonfio, girato a fatica verso di me, tutto era sporgente in questo volto, le guance, il naso, le labbra.
Questa era, in tutto il mese, l’unica variazione importante durante la quale mi lasciavo un po’ andare; se per caso era rimasta un po’ di grappa, la mandavo giù subito dopo la partenza dell’ispettore, per lo più sentivo ancora il segnale di partenza del treno mentre il liquido mi scivolava in gola. La sete di una notte simile era terribile; era come se in me ci fosse un secondo uomo che sporgeva testa e collo dalla mia bocca per chiedere urlando qualcosa da bere. L’ispettore era ben fornito, si portava dietro in treno sempre una buona provvista da bere, io invece dovevo adattarmi a quel che restava.
Per tutto il mese però non bevevo nulla e non fumavo, facevo il mio lavoro e non desideravo altro. Come ho detto, non era un gran lavoro, e lo eseguivo con scrupolo. Per esempio avevo il compito di pulire e controllare ogni giorno i binari un chilometro a destra e uno a sinistra dalla stazione. Io però non mi limitavo a questa disposizione e andavo spesso molto più lontano, tanto lontano che potevo a malapena vedere ancora la stazione. Quando l’aria era limpida questa era visibile fino a cinque chilometri, perché il terreno era perfettamente pianeggiante. Quando ero tanto lontano che la capanna mi scintillava in lontananza davanti agli occhi, mi sembrava per miraggio che tanti puntini neri si muovessero su e giù davanti ad essa. Erano intere compagnie, intere truppe. A volte però veniva davvero qualcuno, e allora, agitando la zappa, rifacevo di corsa tutta la lunga strada a ritroso.
Verso sera il mio lavoro era finito e mi ritiravo definitivamente dentro la capanna. Di solito a quest’ora non avevo visite, perché il ritorno nei paesi, di notte, non era del tutto sicuro. Nei dintorni si aggirava della gentaglia, non di residenti però; ogni tanto cambiavano, ma tornavano sempre. La maggior parte li avevo visti, la stazione solitaria li attirava, non erano propriamente pericolosi ma bisognava essere severi con loro.
Erano gli unici che mi disturbassero durante i lunghi crepuscoli. Altrimenti rimanevo sulla panca, non pensavo al passato, non pensavo alla ferrovia, il prossimo treno sarebbe passato solo fra le dieci e le undici di sera, insomma non pensavo proprio a niente. Ogni tanto leggevo qualche vecchia rivista che mi avevano lanciato dal treno e che conteneva storie scandalistiche di Kalda che mi avrebbero interessato ma che non riuscivo a ricostruire dai numeri così isolati. Oltre a ciò, in ogni numero c’era la continuazione di un romanzo che si intitolava "la vendetta del comandante". Questo comandante, che portava sempre un pugnale al fianco e in una particolare occasione lo teneva persino fra i denti, una volta l’ho anche sognato. D’altronde non potevo leggere molto, perché scendeva presto il buio e il petrolio e le candele di sego avevano un prezzo esorbitante. Dalla ferrovia ricevevo ogni mese soltanto mezzo litro di petrolio che finivo di usare ben prima che finisse il mese solo per accendere il segnale per il treno una mezz’ora la sera. Ma nemmeno questa luce era necessaria, e più tardi, almeno nelle notti di luna, non la accesi neppure più. Assai giustamente prevedevo che, passata l’estate, avrei avuto ben più grande necessità di petrolio. Perciò scavai un buco in un angolo della capanna, vi posi un vecchio barilotto di birra e ogni mese vi versavo il petrolio risparmiato. Il tutto era coperto di paglia e nessuno lo notò. Quanto più la capanna puzzava di petrolio, tanto più ero contento; l’odore era così forte perché il barilotto era di legno marcito, e si era completamente impregnato di petrolio. Più tardi per prudenza seppellii il barilotto fuori della capanna, perché una volta l’ispettore aveva fatto lo spaccone davanti a me con una scatola di cerini e, siccome li volevo, li gettava accesi nell’aria uno dopo l’altro. Tutti e due, e soprattutto il petrolio, correvamo un reale pericolo, io salvai la situazione stringendolo al collo finché ebbe lasciato cadere tutti i cerini.
Nelle ore libere pensavo spesso a come organizzarmi per l’inverno. Se già ora, nella stagione calda, mi sentivo gelare - e la gente diceva che da molti anni non faceva così caldo - quando fosse giunto l’inverno me la sarei cavata molto male. Che avessi accumulato il petrolio era stata solo una bizzarria, avrei dovuto ragionevolmente mettere da parte per l’inverno parecchie cose; non c’era dubbio alcuno che la società non si sarebbe data particolare cura di me, ma io ero troppo incosciente, o per dir meglio non ero incosciente ma mi curavo troppo poco di me stesso per darmi molto da fare in questo senso. Ora nella stagione calda le cose andavano passabilmente, lasciai tutto com’era e non intrapresi nulla.
Una delle possibilità che mi avevano attirato in questa stazione era la prospettiva di praticare la caccia. Mi avevano detto che i dintorni erano straordinariamente ricchi di cacciagione, e avevo già prenotato un’arma che volevo farmi mandare appena avessi risparmiato un po’ di soldi. Ma ora era risultato che di selvaggina da cacciare non c’era l’ombra, qui si potevano incontrare solo lupi e orsi, benché nei primi mesi non ne vedessi neppure uno, e inoltre c’erano qui dei ratti veramente enormi che potei osservare subito mentre, come spinti dal vento, correvano in massa sopra la steppa. Invece la selvaggina in cui speravo non c’era affatto. Non si trattava di una indicazione sbagliata, i dintorni ricchi di selvaggina c’erano veramente, solo si trovavano a tre di giorni di viaggio, - non avevo riflettuto che in queste regioni, che si estendono disabitate per centinaia di chilometri, le indicazioni dei luoghi devono per forza essere imprecise. In ogni caso ora non avevo bisogno dell’arma e potevo usare il denaro per qualcos’altro; per l’inverno però dovevo comunque procurarmi un’arma e a questo scopo mettevo regolarmente una somma da parte. Per i ratti, che di tanto in tanto attaccavano il mio cibo, bastava il mio lungo coltello. Nei primi tempi, quando ancora consideravo tutto con curiosità, infilzai una volta uno di questi ratti e lo tenni davanti a me sul muro all’altezza degli occhi. Gli animali più piccoli si possono vedere bene solo avendoli all’altezza degli occhi; quando ci si piega a terra verso di loro e li si osserva laggiù, se ne ottiene un’immagine falsa e incompleta. La cosa più curiosa in questi ratti erano gli artigli, grandi, un po’ incavati ma appuntiti in cima, erano molto adatti per scavare. Nel suo ultimo spasimo, il ratto sul muro davanti a me allargò e irrigidì gli artigli, si sarebbe detto contro la loro natura vivente, ed erano simili a una piccola mano che si allunga verso qualcuno. In generale questi animali mi davano poco fastidio, solo di notte ogni tanto mi svegliavano quando, correndo rumorosamente sul pavimento duro, filavano via oltre la capanna. Se allora mi mettevo a sedere e accedevo una candela, in qualche buco sotto le assi degli stipiti potevo vedere il lavoro febbrile degli artigli di un ratto, che si infilavano nel buco dal di fuori. Era un lavoro del tutto inutile, perché per procurarsi un buco sufficiente avrebbe dovuto lavorare per giorni interi, mentre fuggiva già alle prime luci del giorno, e tuttavia lavorava come un lavoratore che conosce il suo obiettivo. E il lavoro era buono, sotto il suo scavare volavano via pezzetti di terra magari microscopici, ma l’artiglio non si allungava mai senza risultato. Spesso nella notte stavo a guardare a lungo, finché la regolarità e la tranquillità dello spettacolo mi cullavano nel sonno. Allora non avevo più la forza di spegnere la candela, che ancora per un po’ illuminava il ratto al lavoro. Una volta, in una notte calda, sentendo di nuovo lavorare gli artigli, mi avvicinai con prudenza senza accendere luci, per vedere proprio l’animale. Questi aveva piegato molto in basso la testa dal muso aguzzo, quasi spingendola fra le zampette anteriori per avvicinarsi il più possibile al legno e spingere il più profondamente possibile gli artigli sotto il legno. Si sarebbe potuto credere che qualcuno nella capanna tenesse saldi gli artigli per tirare dentro tutto l’animale, tanta era la tensione. Eppure, tutto era già finito dopo un calcio, con il quale stesi morto l’animale. Del tutto sveglio, non potevo permettere che si attaccasse la capanna, che era il mio unico possesso.
Per assicurare la capanna contro i ratti, tappai tutti i buchi con paglia e stoppa, e ogni mattino controllavo il terreno intorno. Avevo in mente poi di coprire il pavimento della capanna, fino ad allora di semplice terra battuta, con delle assi di legno, cosa che sarebbe anche stata utile per l’inverno. Un contadino di nome Jekoz, dal villaggio più vicino, mi aveva promesso da tempo che avrebbe portato a questo scopo delle belle assi asciutte, per questa promessa lo avevo anche ospitato diverse volte, non restava mai via lungo tempo, ma veniva ogni due settimane, e a volte faceva anche spedizioni attraverso la ferrovia, ma non mi portò le assi. Si scusava di questo in molti modi, per lo più affermando di essere troppo vecchio per trascinare un simile peso e che suo figlio, che avrebbe portato le assi, era occupato nei campi. Jekoz diceva di essere molto oltre la settantina, e anche il suo aspetto lo confermava, però era un uomo alto e ancora molto forte. Inoltre cambiava le sue giustificazioni, e un’altra volta parlò della difficoltà di procurarsi assi così lunghe come io avevo bisogno. Io non insistei, le assi non mi erano indispensabili, Jekoz stesso mi aveva dato l’idea di ricoprire il pavimento, forse una simile copertura non era neppure vantaggiosa, insomma, potevo stare a sentire tranquillo le bugie del vecchio. Tutte le volte il mio saluto era: "Le assi, Jekoz!" Subito cominciavano allora, in un linguaggio mezzo balbettante, le giustificazioni, mi sentivo chiamare ispettore o capitano, o anche solo telegrafista, mi prometteva non solo di portare le assi la prossima volta, ma di demolire con l’aiuto del figlio e di alcuni vicini tutta la mia capanna per costruire una abitazione solida al suo posto. Io lo stavo a sentire, finché mi stancavo e lo spingevo fuori. Ancora sulla porta tuttavia alzava per chiedere scusa le braccia apparentemente così deboli, con le quali in realtà avrebbe potuto schiacciare un adulto. Io sapevo perché non portava le assi, pensava che, avvicinandosi l’inverno, ne avrei avuto un bisogno più urgente e le avrei pagate meglio, inoltre lui stesso, finché non mi forniva le assi, aveva un maggior valore ai miei occhi. Naturalmente non era uno stupido e sapeva che intuivo i suoi pensieri, ma vedeva per sé un vantaggio nel fatto che io non sfruttavo quel che intuivo, e quel vantaggio voleva conservarlo.
Ma tutti i preparativi che facevo per proteggermi dagli animali e premunirmi per l’inverno dovettero interrompersi perché - già si avvicinava la fine del mio primo trimestre di lavoro - mi ammalai gravemente. Fino ad allora, per anni, ero rimasto indenne da ogni malattia e anche dal più leggero malessere, questa volta però mi ammalai. Cominciò con una forte tosse. A circa due ore dalla stazione, verso l’interno, c’era un piccolo torrente dove ero solito prendere la mia riserva d’acqua, mettendola in un barile sopra una carriola. Laggiù facevo spesso anche il bagno, e la tosse ne fu una conseguenza. Gli attacchi di tosse erano talmente forti che tossendo dovevo piegarmi in due, credevo di non poter resistere alla tosse se non mi piegavo raccogliendo così tutte le forze. Pensavo che il personale del treno si sarebbe spaventato di quella tosse, ma loro la conoscevano e la chiamavano la tosse del lupo. Da allora cominciai a sentire, nella tosse, l’ululato. Sedevo sulla panchina nella capanna e ululando salutavo l’arrivo del treno, ululando ne accompagnavo la partenza. Di notte mi inginocchiavo sulla panca anziché stare sdraiato, e premevo il viso nelle pelli per risparmiarmi almeno di udire l’ululato. Aspettavo teso che la rottura di qualche vaso più importante ponesse fine a tutto. Ma non successe niente del genere e in alcuni giorni la tosse era addirittura sparita. Restò però una febbre, che non passò.
Questa febbre mi rese molto stanco, persi ogni capacità di resistenza, succedeva a volte che del tutto inaspettatamente la fronte mi si coprisse di sudore, allora tremavo in tutto il corpo e ovunque mi trovassi dovevo mettermi sdraiato e aspettare, finché mi ritornassero i sensi.

