 |
 |
|||

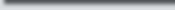
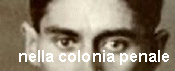
La giustizia con le ali ai piedi. Analisi di congiura e processo in Der Prozess di Franz Kafka
Matteo Colombi, Università di Bologna

.
È la giustizia – disse infine il pittore. - Oh, adesso la riconosco, - disse K., - qui c’è la benda sugli occhi e qui la bilancia. Ma perché ha anche le ali ai piedi e sta correndo?-
(F. Kafka, Der Prozess)
I volti del Tribunale
Al momento di analizzare Der Prozess (Il Processo, prima edizione postuma 1925) constata Giuliano Baioni in una sua monografia su Kafka: «La critica sembra essere concorde su un punto solo: K. è colpevole di non conoscere la legge. Ma quale legge? È la legge divina? È la legge mondana? E che rappresenta il tribunale? È una ulteriore versione dell’immagine del padre o è la burocrazia austroungarica? È un prodotto della nevrosi d’angoscia o è la burocrazia religiosa del popolo ebraico?» (1963, p. 145). A queste si collega «la prima, fondamentale domanda che il romanzo pone al lettore: quale colpa ha commesso K.?» (p. 148). Questo saggio vuole far proprie queste domande e, più che fornire una risposta, vuole vagliare alcune risposte possibili. Intende concentrarsi sul modo in cui Kafka ha creato un caso giudiziario di cui non si capisce se l’imputato sia colpevole o innocente e, d’altro canto, se il tribunale che lo accusa e lo condanna sia legittimo o illegittimo. In questa ambiguità che pervade il testo risiede anche il suo rapporto con il tema della congiura: se infatti Josef K. risultasse essere innocente e il tribunale illegittimo, il titolo dell’opera andrebbe rovesciato e saremmo di fronte ad una congiura perpetrata da una tanto potente quanto impenetrabile associazione segreta ai danni del protagonista.
A dividere i concetti di congiura e processo è infatti il principio di legittimità, che a sua volta risiede in quello di legge: un processo è uno scontro tra parti che avviene 'nella legge', una congiura uno scontro che ne avviene 'al di fuori'. Per questo la considerazione più immediata è che i processi siano 'buoni' e le congiure 'cattive': i processi sono dalla parte della legge e la legge è per definizione buona.
L’intento del mio lavoro è di mostrare come Kafka non percepisca questa distinzione fra 'dentro e fuori' la legge come una distinzione solida: per lui non è più possibile definire con certezza cosa sia legge. In Der Prozess egli si chiede in cosa la natura della legge sia diversa da quella della violenza e dell’arbitrio: il tribunale del romanzo si definisce legge e tuttavia sembra essere un potere arbitrario e corrotto che opprime uomini innocenti con la violenza (da quella più sottile della burocrazia fino al picchiatore e ai sicari di K.).
Prima di prendere in esame il testo di Kafka vorrei definire alcune categorie utili per l’analisi del problema 'legge-congiura-processo' a partire dallo studio di Walter Benjamin Per una critica della violenza, del 1921[1]. In questo saggio il filosofo si propone di indagare i rapporti che intercorrono fra i concetti di «violenza», «potere» e «legge». Benjamin parla di
un’altalena dialettica tra le forme della violenza che pone e conserva il diritto. La legge di queste oscillazioni si fonda sul fatto che ogni violenza conservatrice indebolisce, a lungo andare, indirettamente, attraverso la repressione delle forze ostili, la violenza creatrice che è rappresentata in essa. [...] Ciò dura fino al momento in cui nuove forze, o quelle prima oppresse, prendono il sopravvento sulla violenza che finora aveva posto il diritto, e fondano così un nuovo diritto destinato a una nuova decadenza. (Benjamin 1995, p. 29).
Per il filosofo, almeno in questo saggio, la legge, il diritto, coincide con un’alternanza di poteri che si susseguono l’uno all’altro attraverso l’esercizio della violenza. Volendo situare in questa dinamica i processi e le congiure, risulta che ogni trapasso da uno stato di diritto ad un altro può essere visto contemporaneamente come entrambi: dal punto di vista della legge che decade esso è una congiura ai suoi danni (accade 'al di fuori' di lei, perché ne sovverte con la violenza i principi), dal punto di vista della legge che si afferma è un giusto processo storico e giuridico ad un sistema sbagliato (accade 'dentro' una nuova, giusta legge). In definitiva secondo Benjamin non è né l’una né l’altro, bensì un mero rapporto di forza tra chi detiene il potere (uso «conservativo» della violenza) e chi lo vuole scalzare (uso «creativo» della violenza). Può sembrare che le riflessioni di Benjamin siano estremistiche: lo stato moderno ha faticosamente avviato processi democratici in cui lo scontro fra le parti si dovrebbe risolvere in un dialogo, nella capacità di stringere accordi e di mediare. Benjamin cerca di dimostrare che, dietro l’apparenza, il sistema di diritto degli stati moderni (in tutti i suoi aspetti, dallo sciopero al parlamentarismo) risponde sempre alla logica della violenza. A proposito del contratto giuridico egli scrive che «per quanto sia stato concluso pacificamente dai contraenti, conduce sempre, in ultima istanza, a una possibile violenza. Poiché esso conferisce ad ogni parte il diritto di ricorrere, in qualche forma, alla violenza contro l’altra, nel caso che questa volesse violare il contratto» (p. 17).
Benjamin non esclude che gli uomini possano entrare in relazione anche senza ricorrere alla violenza: «È in generale possibile il regolamento non violento di conflitti? Senza dubbio. I rapporti fra privati ne offrono esempi a iosa [...] Basti quindi accennare a mezzi puri della politica come analoghi a quelli che governano i pacifici rapporti fra persone private» (pp. 18 e p. 21). D’altro canto ritiene che «ogni modo di concepire una soluzione di compiti umani, per tacere di un riscatto dalla schiavitù di tutte le passate condizioni storiche di vita, rimane irrealizzabile se si esclude assolutamente e in linea di principio ogni e qualsiasi violenza» (p. 22). L’approccio di Benjamin al problema è inusuale: invece di condannare la violenza perché lede il diritto, egli condanna il diritto perché altro non è che violenza mascherata, che si presenta come un giusto sistema di leggi solo per mantenere al potere i più forti (o per portarveli, nei cicli e ricicli della storia). Più precisamente il male del diritto non sta nel suo essere violento - di violenza non si può fare del tutto a meno se si vuole riscattare l’uomo dai mali della sua storia - bensì nell’essere violento a vantaggio di una logica di potere. Benjamin si chiede allora se esistano «altre forme di violenza da quella presa in considerazione da ogni teoria giuridica» (p. 22), forme pure che non agiscono per la conservazione o conquista del potere, forme che si potrebbero definire 'giuste'.
Poiché ogni forma storica di violenza è legata al diritto ed è irrimediabilmente guasta, Benjamin risale al mondo del mito e analizza la natura specifica della violenza così come si manifesta in esso. A prima vista essa non sembrerebbe legata al concetto di legge: «La violenza mitica nella sua forma esemplare è semplice manifestazione degli dei. Non mezzo ai loro scopi, appena manifestazione della loro volontà, essa è soprattutto manifestazione del loro essere» (p. 23). Eppure anche la violenza degli dei del mito ha il suo motivo di esistere nella logica del potere: essa deve mostrare agli uomini che gli dei sono più potenti di loro e non possono essere sfidati. Sebbene gli dei non costruiscano un sistema di leggi organizzato, «confini posti e definiti restano, almeno nelle epoche primitive, leggi non scritte. L’uomo può superarli senza saperlo e incorrere così nel castigo. Poiché ogni intervento del diritto provocato da un’infrazione della legge non scritta e non conosciuta è, a differenza della pena, castigo» (p. 25). Gli dei si fanno violenza gli uni agli altri e fanno violenza all’uomo per ribadire la loro superiorità. La violenza mitica non è al di fuori dalla logica del potere, solo che in essa il potere non è già sancito da leggi, ma agisce più come un 'destino', una forza misteriosa che si scatena contro chi sorpassa i limiti. La violenza storica, la violenza del diritto, nasce in fondo da quella mitica nel momento in cui alcuni uomini si fanno garanti del 'destino' voluto dagli dei e promulgano leggi in suo nome. Da sistemi giuridici 'religiosi' si passa a sistemi laici, dal destino si passa alla legge, senza che però la logica del potere che sta alla base ne venga intaccata.
Benjamin è però convinto che esista una terza forma di violenza, distinta da quella giuridica e da quella mitica e non assoggettata al potere: «Alla violenza mitica si oppone quella divina, che ne costituisce l’antitesi in ogni punto. Se la violenza mitica pone il diritto, la divina lo annienta, se quella pone limiti e confini, questa distrugge senza limiti, se la violenza mitica incolpa e castiga, quella divina purga ed espia…» (p. 26). Il filosofo sostiene che il potere di Dio non si manifesta con violenza né per palesare la propria potenza né per instaurare una legge che la salvaguardi, bensì per purificare l’uomo e l’universo. È una considerazione che apre al dibattito: se è al Dio di Isacco e di Giobbe che Benjamin pensa, come è possibile che il filosofo non prenda in considerazione tutti i limiti e tutti i castighi che Egli ha imposto o minacciato agli Ebrei[2], quando essi non avessero ubbidito alle sue leggi? Sembra inevitabile porsi il problema di Giobbe: come è possibile distinguere la natura 'giusta' della violenza divina dal puro sopruso? Giobbe giungerà alla conclusione che l’uomo non può pretendere di comprendere a fondo la giustizia di Dio, e la sua scommessa è piuttosto quella di accettarla anche quando non gli sembra tale. Benjamin non si pone esplicitamente nel saggio questo problema, ma forse la sua conclusione può fungere da (mezza) risposta: «Poiché solo la violenza mitica, e non quella divina, si lascia riconoscere con certezza come tale […]. Di nuovo sono a disposizione della pura violenza divina tutte le forme eterne che il mito ha imbastardito col diritto. Essa può apparire nella vera guerra come nel giudizio della folla sul delinquente […]. La violenza divina, che è insegna e sigillo, mai strumento di sacra esecuzione, è la violenza che governa» (pp. 29-30). I limiti ed i castighi di Dio agli Ebrei possono essere intesi o come imbastardimento che il mito, la narrazione umana, ha fatto della giustizia divina tentando di ricostruirne le ragioni, o come sua apparizione, senza che però l’uomo possa comprenderne il disegno. Non è una risposta così diversa da quella di Giobbe: in entrambi i casi, l’azione divina non lascia comprendere all’uomo la logica della sua giustizia.
Josef K. condivide con Benjamin e Giobbe il problema di una giustizia paradossale: essa ha tutti i tratti della violenza mitica mascherata da (evolutasi in) diritto positivo, eppure potrebbe essere anche una forma 'divina' della violenza, all’apparenza meschina e incomprensibile ma comunque giusta. In Der Prozess sono presenti tutti e tre i volti della violenza di cui parla Benjamin: diritto, destino e Dio. Il tribunale raccoglie in sé le caratteristiche di ciascuno. Josef K. si chiede quale dei tre volti sia quello vero senza però fornire una risposta chiara. Torniamo dunque alla macchina delle ambiguità in cui non si riesce a dire chi sia innocente e chi colpevole, se si assista ad un processo o ad una congiura. Alla luce delle riflessioni di Benjamin dovrebbe però essere chiaro fin d’ora che questa ambiguità non è poi così artificiosa e surreale come può sembrare: essa sfrutta contraddizioni di per sé insite nel concetto di legge, per cui le definizioni di processo e congiura si svincolano da quelle di bene e di male e dipendono da meri equilibri di potere. È però sempre possibile riscattare questa desolata visione della legge attraverso il richiamo all’imperscrutabilità della legge divina: ciò che ci sembra aberrante può al contrario rispondere a inintelligibili criteri di giustizia.
Si tratta adesso di vedere in concreto come faccia il testo a produrre queste alternative.
Le leggi del Processo
«Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet» (p. 9) [«Qualcuno doveva aver calunniato Josef K. perché un mattino, senza che avesse fatto nulla di male, fu arrestato» (p. 3)][3]. Così si apre Der Prozess. La frase è cruciale perché orienta le attese del lettore. Egli legge che Josef K. è innocente. Un innocente contro cui viene intentato un processo ingiusto, cioè una congiura ai suoi danni. Anche K. la pensa allo stesso modo, come è chiaro dalle sue reazioni all’arresto, e per tutto il libro, se escludiamo l’ultimo capitolo, si dichiarerà innocente. Man mano che la storia si dipana, protagonista e lettore vengono però sconcertati dalla piega degli eventi: quella che appare palesemente una congiura viene definita da tutti come corretta applicazione della legge. Josef K. si rende pian piano conto del fatto che la legge cui è abituato non ha nulla a che vedere con la legge che di fatto lo giudica.
K. si sveglia una mattina e non può lasciare la pensione dove vive perché due sconosciuti gli fanno presente che è in arresto. Perplesso, si chiede chi siano e aggiunge tra sé che «lebte doch in einem Rechtsstaat, überall herrschte Friede, alle Gesetze bestanden aufrecht, wer wagte ihn in seiner Wohnung zu überfallen?» (p. 12) [«viveva in uno stato di diritto, dappertutto regnava la pace e tutte le leggi erano in vigore: chi si permetteva di entrare in casa sua per sopraffarlo?» (p. 6)]. Ipotizza di essere vittima di uno scherzo dei colleghi in occasione del suo compleanno.
Sennonché è proprio uno di quei due sconosciuti che lo hanno in custodia a dichiarare di agire per conto dei rappresentanti della legge: K. sta cercando di far chiarezza sulla sua situazione e chiede di cosa sia accusato e poi esibisce anche alcuni documenti. La guardia Willem si irrita e gli spiega:
Es gibt darin keinen Irrtum. Unsere Behörde, soweit ich sie kenne, und ich kenne nur die niedrigsten Grade, sucht doch nicht etwa die Schuld in der Bevölkerung, sondern wird, wie es im Gesetz heißt, von der Schuld angezogen und muss uns Wächter ausschicken. Das ist Gesetz. Wo gäbe es da einen Irrtum? (p. 14)
[Non c’è errore possibile. I nostri superiori, a quanto io so di loro, e conosco solo i gradi più bassi, non è che cerchino le colpe nella popolazione, ma vengono attratti dalle colpe: è così che dice la legge. E mandano in giro noi guardie. Questa è la legge; come ci potrebbe essere un errore? (p. 9)]
La legge è infallibile e decreta l’infallibilità di chi la esercita. Tale infallibilità si giustifica per la guardia in una tautologia: è legge e dunque non sbaglia.
K. ribatte di non conoscere questa legge e dichiara che è solo «scritta nelle teste» delle due guardie. Queste commentano fra loro: «Sieh Willem er gibt zu, er kenne das Gesetz nicht und behauptet gleichzeitig schuldlos zu sein. - Du hast ganz Recht, aber ihm kann man nichts begreiflich machen» (p. 15) [«'Hai visto, Willem? Ammette di non conoscere la legge, e insieme dice che è innocente.' 'Hai ragione, ma è uno che non vuole capire'» (p. 9)].
Il conflitto esplode nel secondo capitolo quando K. si lancia in un’arringa del suo concetto di legge di fronte al giudice istruttore:
Es ist kein Zweifel, dass hinter allen Äußerungen dieses Gerichtes [...] eine große Organisation sich befindet. Eine Organisation, die nicht nur bestechliche Wächter, läppische Aufseher und Untersuchungsrichter, die günstigsten Falles bescheiden sind [...]. Und der Sinn dieser großen Organisation, meine Herren? Er besteht darin, dass unschuldige Personen verhaftet, und gegen sie ein sinnloses und meistens wie in meinem Fall ergebnisloses Verfahren eingeleitet wird. Wie ließe sich bei dieser Sinnlosigkeit des Ganzen, die schlimmste Korruption der Beamtenschaft vermeiden? Das ist unmöglich, das brachte auch der höchste Richter nicht einmal für sich selbst zustande. (p. 56)
[Non c’e’ alcun dubbio che dietro tutte le manifestazioni di questo tribunale (...) si nasconde una grossa organizzazione. Un’organizzazione che non solo dà lavoro a guardiani corrotti, a ispettori scriteriati, e a giudici, per ben che vada, modesti (...). E qual è il senso di questa organizzazione signori miei? Il senso è questo di arrestare persone innocenti, e di istruire a loro carico un procedimento assurdo, e per lo più, come nel mio caso, privo di conclusione. Data questa assurdità, come si potrebbe evitare la più abbietta corruzione di tutta la gerarchia? Non la si può evitare, non riuscirebbe a sottrarvisi nemmeno il più alto dei giudici. (pag. 52)]
Arrestare gli innocenti non può essere per K. lavoro da uomini di legge, né la corruzione può elevarsi a regola in un tribunale.
Nonostante K. sembri molto risoluto a opporre le proprie ragioni a quelle dei suoi accusatori, e sia convinto di agire nella legge e da uomo innocente, egli entrerà sempre più nelle logiche del tribunale nel corso del romanzo. Se nel primo capitolo la legge che lo accusa esisteva per lui solo nella testa delle due guardie, in seguito essa occuperà sempre più spazio anche nella sua.
Nel corso del romanzo sarà sempre più evidente che K. non potrà che soccombere al suo processo: l’autore ha attribuito alla legge del tribunale poteri divini. K. non può riuscire a sconfessarla: per quanto ripugnante, essa è l’unica possibile e se lo ha decretato colpevole egli lo deve essere. K. dapprima si opporrà a questo ragionamento, ma poi inizierà a crederci: egli ha sempre sostenuto a spada tratta la propria innocenza, ma se prima gli bastava dichiararla ora è ossessionato dall’idea di doverla provare. Per questo motivo ha tolto l’incarico della sua difesa all’avvocato Huld. Dispera però di riuscirci: gli mancano semplicemente le forze per passare in rassegna tutta la sua vita e verificare se davvero non si sia mai macchiato di una colpa (secondo quale legge?). Egli non parla più dell’ingiustizia del tribunale ma solo della necessità di farsi dichiarare innocente. Se non considera giusto il proprio processo sembra ormai ritenerlo parte inevitabile della sua vita. Nell’ultimo capitolo giungerà addirittura a credere di esser veramente colpevole.
È evidente che Der Prozess è costruito sull’opposizione di differenti concetti di legge[4]: la legge come la ha in mente K. è la legge del diritto positivo che nasce per tutelare l’uomo in società. Noi abbiamo visto che l’altra faccia di questa legge è il potere, e che essa non è per forza così rassicurante come dichiara di essere, ma a tutto questo K. non sta certo pensando. Egli ha in mente la legge che tutela gli innocenti e che se accusa dichiara sempre la natura della colpa. Kafka scende anche nei particolari, di là dai nobili principi del diritto: è la legge che quando arresta richiede i documenti. La legge delle guardie e dell’ispettore non vi ha niente a che fare. Tanto per cominciare va a caccia di colpevoli (è attratta dalle colpe): è vero che la legge positiva per tutelare gli innocenti dà la caccia ai colpevoli, ma è anche vero che essa non può di norma mettersi in moto senza una denuncia (inoltre il romanzo si apre con una dichiarazione dell’innocenza di K). Questa legge sembra un po’ troppo 'volitiva'[5]. In secondo luogo è segreta: i suoi rappresentanti non la conoscono, così come non possono dire a K. in cosa consista la sua colpa. Infine è infallibile. Questa legge ha delle affinità con la violenza mitica di cui ci parla Benjamin (che del resto vuol proprio dimostrare come la legge positiva, di là dalle apparenze, sia esattamente volitiva quanto quella mitica nell’eliminare chiunque tenti di minarne il potere). Il tribunale di Der Prozess può prendere l’iniziativa, non è per forza detto che dia ragione dei propri ordini, e si impone grazie al superiore potere che detiene de facto. Eppure si pone al di sopra del mito perché è anche giusto, cioè possiede il carattere che Benjamin attribuisce alle azioni divine. Vi è però anche una differenza: la violenza divina ha una sua origine chiara in Dio, qui non è detto nulla del suo creatore. È una distinzione cruciale: l’origine divina stabilisce la legittimità e infallibilità del proprio agire. La legge che arresta K., stando alle parole della guardia Willem, si giustifica in quanto legge, non ha bisogno di origine. Svolge da sé la mansione di Dio. Kafka accentua attraverso la legge del tribunale il paradosso della legge divina di Giobbe[6]:quest’ultima appare alla ragione umana identica per violenza alla legge mitica, ma a distinguerla è Dio stesso che liberamente si richiama alla giustizia nelle parole con cui si rivela agli uomini[7]. In Der Prozess di Kafka non appare nessun Dio, nessun creatore di tutte le cose che, se non spiega la giustizia, se ne fa quanto meno garante. Ricorrendo alle categorie di Benjamin, risulta che il tribunale rimane sospeso tra violenza mitica e violenza divina: infatti esso si proclama non solo di superiore potenza (come gli dei del mito), ma anche giusto (come Dio), senza che però una sua 'rivelazione' intervenga a legittimare questa pretesa. A Josef K. non appaiono che funzionari e giudici di infimo grado. Dirà il pittore Titorelli:
Die untersten Richter nämlich, zu denen meine Bekannten gehören, haben nicht das Recht endgültig freizusprechen, dieses recht hat nur das oberste, für Sie und für uns alle ganz unerreichbare Gericht. Wie es dort aussieht, wissen wir nicht und wollen wir nebenbei gesagt auch nicht wissen. (p. 166)
[Voglio dire che i giudici inferiori, di cui fanno parte tutti quelli che io conosco, non hanno il diritto di assolvere definitivamente; questo diritto ce lo ha solo il tribunale supremo a cui non può arrivare né lei, né io, né nessuno di noi tutti. Come stiano le cose lassù non lo sappiamo, né, sia detto per inciso, lo vogliamo sapere. (pag. 172)]
Per riprendere le argomentazioni di Benjamin si potrebbe anche aggiungere che, secondo il filosofo, la violenza divina si distingue «per il carattere non sanguinoso, fulmineo, purificante dell’esecuzione. Infine, per l’assenza di ogni creazione di diritto» (Benjamin 1955, p. 27). Se è vero che in Der Prozess non compare sangue, nemmeno nelle scene di violenza, è vero anche che l’azione del tribunale è per K. una lenta tortura e l’immagine che esso da di sé è ben poco salubre e purificante. Inoltre esso sembra sepolto dalle carte della legge (o meglio: da quelle intorno alla legge), dalle petizioni degli avvocati, dalle lettere informali.
I primi capitoli del romanzo già ci mostrano come Kafka realizzi la contrapposizione e mescolanza di idee di legge diverse tra loro. Egli gioca sul contrasto tra la legge 'normale' del diritto positivo e la legge mistica che fa irrompere nella vita del suo protagonista, un procuratore di banca dell’era borghese. Crea il paradosso poiché attribuisce alla seconda il potere sulla realtà: le dà così la legittimazione de facto che il senso comune attribuisce alla prima. Il paradosso però non è uno soltanto: la stessa legge mistica ne cela un secondo al suo interno, poiché si proclama 'giusta' al pari di quella divina, ma non vi è un Dio a rivelarla e a farsene garante. PROPRIO PER QUESTO ADOTTO QUI IL TERMINE “MISTICA” PER DEFINIRE LA LEGGE DI KAFKA. RISPETTO ALLE CATEGORIE DI BENJAMIN CHE HO PRESENTATO NEL PRIMO CAPITOLO ESSA NON È NÉ SICURAMENTE MITICA (NON È MANIFESTAZIONE SOPRA-UMANA DI POTERE E SUPERIORITÀ CHE PONE DEI LIMITI ALL’UOMO) NÉ SICURAMENTE DIVINA (NON È MANIFESTAZIONE SOPRA-UMANA CHE PURIFICA L’UOMO E SPAZZA VIA I VINCOLI DI POTERE IN CUI LUI STESSO HA POSTO SÉ, I SUOI SIMILI E LA STORIA). SI PRESENTA A VOLTE COME L’UNA A VOLTE COME L’ALTRA, E GIOCA SUL FATTO CHE ENTRAMBE VEDONO UN FONDAMENTO SOPRA-UMANO ALLA BASE DELLA LEGGE. IL TESTO DI DER PROZESS NON PERMETTE PERÒ DI RICONOSCERE UNO DI QUESTI DUE VOLTI DELLA LEGGE , MITICO E DIVINO, COME VERO E L’ALTRO COME FALSO: PRESENTA UN INDISTINTO VOLTO MISTICO CHE A SUA VOLTA SI MESCOLA A UNA RAPPRESENTAZIONE POSITIVA DEL DIRITTO COMPIENDO IL PARADOSSO.
Voler indicare il significato di tale paradosso è estremamente problematico: per tornare alle categorie di Benjamin, non si può dire se Kafka intenda in Der Prozess fare in chiave grottesca una critica ai residui mitici del diritto positivo moderno, che sfrutta la legge come paravento per l’esercizio violento del potere, oppure se, muovendosi all’interno di un'ottica non mitica, bensì divina, voglia porre il problema della teodicea in un’epoca che non può contare più sulla rivelazione di Dio a Giobbe per risolverlo[8].
Kafka e i totalitarismi
Tra le diverse interpretazioni del mondo paradossale di Der Prozess, quelle di Hannah Arendt e Günther Anders sono entrambe a sfondo politico, ma hanno letto in modo opposto il paradosso della legge[9].
Di Hannah Arendt prendo in considerazione il saggio Franz Kafka (1976), dove la filosofa illustra il significato di Der Prozess e del suo tribunale, e commenta: «Il potere della macchina, che afferra e uccide K., non è altro che l’apparire della necessità, che si può realizzare attraverso l’ammirazione degli uomini per la necessità stessa. La macchina entra in funzione, perché la necessità è ritenuta qualcosa di sublime e perché il suo automatismo, che è spezzato solo dall’arbitrio, viene preso per il simbolo della necessità» (p. 98). K. soccombe nel momento in cui comincia a credere che la legge sia necessaria (nel senso filosofico) e dunque insindacabile: «Il male del mondo in cui gli eroi di Kafka si invischiano, è proprio la sua divinizzazione, la sua arroganza nel rappresentare una necessità divina» (p. 98). La Arendt avvicina espressamente questo mondo ai totalitarismi: in entrambi la legge, che secondo la studiosa deve sapersi rinnovare in base ai bisogni dell’uomo, è considerata immutabile. Secondo la sua interpretazione Kafka ha creato questo paradosso perché già negli anni ‘10 intuiva la degenerazione del sistema borghese e voleva sconfessarla. Invece di farlo apertamente ha creato un mondo che ne inscenasse la tragica assurdità. Per dirla con le nostre categorie, secondo la Arendt il processo va rovesciato in una congiura del diritto positivo contro l’uomo: congiura perché la legge che vuole instaurare (l’insindacabilità delle sue disposizioni) non è altro che la logica del potere della violenza mitica. Poiché però è il diritto positivo ad avere il potere nelle proprie mani, la congiura è de facto un processo. Compito del protagonista sarebbe quello di smascherarlo come congiura e di opporvisi, ma egli si lascia vincere dalla pretesa necessità del diritto, si lascia privare di ogni orizzonte del possibile e accetta la sentenza: in principio egli aveva osato immaginare un diritto positivo al servizio dell’uomo e per questo viene ora punito.
La Arendt dissente da tutti quei critici che hanno pensato che K. credesse davvero ad una legge divina senza Dio ed incomprensibile. Essi avrebbero fatto di un uomo attento un profeta senza Dio. È curioso notare che tra questi uomini c’è anche il primo marito di Hannah Arendt, il filosofo Günther Anders. Il suo saggio Kafka. Pro e contro è del 1951 e riprende una conferenza dal titolo Teologia senza Dio che Anders aveva tenuto all’Institut d’ètudes germaniques di Parigi nel 1934[10]. Già il titolo della conferenza indica che Anders è tra gli interpreti criticati dalla Arendt: egli dà infatti importanza alla natura divina che la legge assume in Kafka e non pensa che essa sia solo la mano di vernice che permette all’autore di far risaltare meglio gli abusi del diritto positivo. Ma la religione di Kafka è di per sé un paradosso: è un ateismo che si vergogna. La sua coscienza oscilla perennemente tra consapevolezza e rimpianto. Da qui scaturisce il suo senso di colpa: egli è colpevole di non sapersi dare alcuna appartenenza. Quando poi prova a darsi una giustificazione metafisica della sua condizione, non riesce a dichiarare apertamente che Dio è morto e che sono gli uomini ad escluderlo. Imbocca allora due strade: divinizza la realtà, per cui l’al di qua diventa al di là (la sua legge infallibile ma senza Dio, immanente alla società) oppure immagina un Dio malvagio nella misura in cui ha creato il male nel mondo e ha poi abbandonato quest’ultimo a sé stesso (Anders 1989, pp. 102-106)[11].
Entrambe queste concettualizzazioni vanno però prese come ipotesi: Kafka infatti le ha contrapposte e rimescolate per tutta la vita senza giungere a una conclusione. Egli rappresenta una situazione che potrebbe essere un processo o una congiura all’uomo, ma non sa scegliere. Il saggio di Anders è critico nei confronti di Kafka, lo giudica pericoloso, e questo è molto raro nella critica che lo riguarda. Infatti secondo il filosofo Kafka è colpevole di non aver detto chiaramente che la legge da lui inscenata è da intendersi come congiura ai danni dell’uomo. È vero che egli non ha nemmeno detto il contrario: però la sua nostalgia dell’assoluto gli ha fatto ipotizzare che 'necessario' è superiore a 'libero' (come dice il cappellano delle carceri nel nono capitolo del romanzo). Anders rovescia l’interpretazione di sua moglie: Kafka non ha affatto inteso aprire gli occhi contro i totalitarismi, bensì ne ha quasi rasentato l’ideologia di uniformazione.
I due filosofi attribuiscono un ruolo esattamente inverso alla componente mistica in Kafka: per la Arendt, Kafka crede nel diritto positivo e mette in guardia dai pericoli di una sua Vergottung, per Anders la sua nostalgia dell’assoluto lo porta all’ipotesi che si possa sacrificare tutto per essa. Anders è però più sfumato: riconosce che a fianco del mistico convive il razionalista e che l’ammissione di colpa di K. rimane ambigua (colpevole di non aver lottato a sufficienza o di aver lottato troppo?).
Kafka era straordinariamente abile a creare paradossi; a mescolare quel che il senso comune teneva separato fino a dare piena evidenza a mondi rovesciati (ma non del tutto: ed è proprio questo che inquieta). In gran parte della sua narrativa ha applicato questa sua capacità al tema della legge e in Der Prozess a quell’ambito particolare che è appunto il processo. Naturalmente ha giocato a mescolarlo con la congiura. In questo ha dimostrato di saper ben manovrare i meccanismi che soggiacciono allo scontro sociale e di conoscerne le ambiguità.
Tanto è vero che il Processo può essere letto anche come una critica al potere, al suo dubbio connubio con la legge e la necessità: così ha fatto Hannah Arendt.
Non è però l’unica interpretazione possibile: Günther Anders ha visto nel Processo un problema religioso, la nostalgia dei valori assoluti e la teologia negativa. Kafka non avrebbe pensato in termini politici la società, bensì religiosi, con il grande rischio che ne deriva: ritornare ad un diritto divino in un’epoca senza dei, ma dove ci sono apparati pronti a sostituirli.
Bibliografia
Anders, Günther
1989 Kafka. Pro e contro. I documenti del processo, Gabriele Corbo Editore, Ferrara.
Arendt, Hannah
1976 Franz Kafka und Franz Kafka: der Mensch mit dem guten Willen, in Eadem, Die verborgene Tradition, Judischer Verlag im Suhrkamp, Frankfurt am Main.
Brod, Max
1956 Kafka, Mondadori, Milano.
Baioni, Giuliano
1984 Kafka: letteratura ed ebraismo, Einaudi, Torino.
1997 Kafka. Romanzo e parabola, Feltrinelli, Milano.
Benjamin, Walter
1995 Angelus Novus, Einaudi, Torino.
Cavarocchi Arbib, Marina
1994 Scholem als Interpret von Kafkas 'Vor dem Gesetz', in Voigts 1994.
Kirchberger, Lida
1986 Franz Kafka’s Use of Law in Fiction, Peter Lang Publishing, New York.
Mayer Hans
1979 Walter Benjamin und Franz Kafka. Bericht über eine Konstellation, «Literatur und Kritik», 14, pp. 579-597.
Scaramuzza, Gabriele, (a cura di)
1994 Walter Benjamin lettore di Kafka, Unicopli, Milano.
Scholem, Gerschom
1993 Le principali correnti della mistica ebraica, Einaudi, Torino.
Voigts, Manfred (a cura di)
1994 Franz Kafka, Vor dem Gesetz, Aufsätze und Materialen, Königshausen & Neumann, Würzburg.
[1] Il saggio non contiene riferimenti diretti a Kafka, tuttavia l’ importante concetto in esso definito di «destino» nel mondo mitico viene sviluppato ed applicato al caso Kafka nel saggio del 1934 Franz Kafka. Nel decimo anniversario della morte (in Benjamin 1995). Sul complesso rapporto fra Benjamin e Kafka si vedano Mayer 1979 e Scaramuzza 1994.
[2] Basti citare la precettistica del Levitico e l’interpretazione di ogni esilio nella storia del popolo ebraico come castigo divino.
[3] Questa e tutte le successive citazioni dal Processo sono tratte da F. Kafka, Der Prozess, Fischer, Frankfurt am Main 1994.; per il testo italiano: Il Processo, traduzione di P. Levi, Einaudi, Torino 1983.
[4] Per un’analisi approfondita dei diversi livelli di significato del concetto di legge in Der Prozess si veda lo studio di Kirchberger 1986, che mette in relazione l’uso che Kafka ne fa in Der Prozess con il resto della produzione kafkiana e affronta il problema anche a partire da nozioni di giurisprudenza nell’ipotesi che Kafka, laureato in legge, vi faccia consapevolmente riferimento.
[5] Una immagine molto chiara di questo 'attivismo' della legge si ha nel capitolo settimo, quando il pittore Titorelli mostra a K. il ritratto che sta facendo di un giudice. Sulla spalliera del trono su cui il giudice è assiso, campeggia una raffigurazione della dea della Giustizia che ha però anche le ali ai piedi e corre come la Vittoria. Titorelli prende a ritoccare il quadro, e sotto gli occhi di K. essa «erinnerte kaum mehr an die Göttin der Gerechtigkeit, aber auch nicht an die des Sieges, sie sah jetzt vielmehr volkommen wie die Göttin der Jagd aus» (p. 154) [«l’immagine non ricordava più la dea della Giustizia e quella della Vittoria ma piuttosto assomigliava alla dea della Caccia.» (p. 160)].
[6] Per il rapporto fra Il processo ed il Libro di Giobbe vd. Baioni 1997, p.146. In particolare la nota 2, in cui l’autore richiama il confronto fra il pensiero di Kafka e il Libro di Giobbe istituito da Max Brod nella sua autobiografia su Kafka (1956, pp. 156-168).
[7] È interessante notare che, se il Dio di Israele pone più volte al centro delle proprie argomentazioni il criterio della giustizia, non lo fa però nel Libro di Giobbe. Dopo aver accusato Giobbe di ignoranza gli dice infatti: «Dov’eri tu quando gettavo le fondamenta della terra?» (Giobbe, 38.4, da La Bibbia, Elle di Ci Leumann-United Bible Societies, Torino-Roma 1985) e prosegue ricordando a Giobbe la sua gloria e la sua potenza. Conclude paragonandosi ad un coccodrillo: «Se nessuno può sfidarlo, tanto è feroce, chi potrà affrontare me?» (41.2). Le parole di Dio ribadiscono la problematicità della distinzione di Benjamin tra legge divina e legge mitica: non sembra infatti di poter distinguere il discorso di Dio da una 'mitica' esibizione di forza superiore che si fa passare come destino e legge.
[8] Le dimensioni di questo saggio non consentono una analisi approfondita di altri importanti episodi del romanzo. Per il problema della legge è comunque di fondamentale importanza citare il capitolo nono, che contiene la parabola della Legge e la sua interpretazione da parte del cappellano delle carceri e di Kafka. L’esegesi che i due fanno della parabola non perviene ad una decifrazione sicura del suo significato, si risolve anzi in un dibattito ermeneutico, ma proprio per questo costituisce il luogo del romanzo dove Kafka svela più chiaramente l’opposizione (e mescolanza) fra i diversi sistemi di legge sui quali esso è costruito: mentre interpreta, K. crede come l’uomo di campagna protagonista della parabola che la legge sia accessibile a tutti ed in ogni momento. Con questa idea della legge è per loro impossibile comprendere i meccanismi della legge imperscrutabile, crudele, perfino meschina e menzognera cui Kafka ha dato pieni poteri nella storia di K. come nella parabola che gli viene raccontata (secondo l’interpretazione dello stesso K., poichè il sacerdote è di diverso avviso). Per una analisi della parabola si vedano in particolare Baioni 1997, pp. 179-191, e Voigts 1994.
[9] I due presentano per altri aspetti affinità di impostazione: entrambi negano risolutamente che Kafka sia un autore del fantastico e ne rivendicano la natura «realista» della scrittura. Un realismo che però agisce per deformazione della realtà, per dirla con Anders, o per esagerata aderenza, per dirla con Hannah Arendt.
[10] Il saggio di Hannah Arendt esce per la prima volta in una rivista americana nel ’44, quando la Arendt si era già definitivamente separata da Anders. È probabile che tenga presente la conferenza del marito.
.
[11] Sui rapporti fra Dio malvagio e religione ebraica ha scritto anche G. Scholem. Egli ha anche riflettuto sulla posizione di Kafka in questa tradizione (Scholem 1993, pp. 264-71). Si veda anche il saggio di M. Cavarocchi Arbib sull’interpretazione che Scholem dà di Kafka (1994).
.
.
Questo saggio è stato pubblicato in: Cospirazioni, trame. Quaderni di Synapsis II. A cura di S. Micali, Le Monnier, Firenze 2003, pp. 167-177

